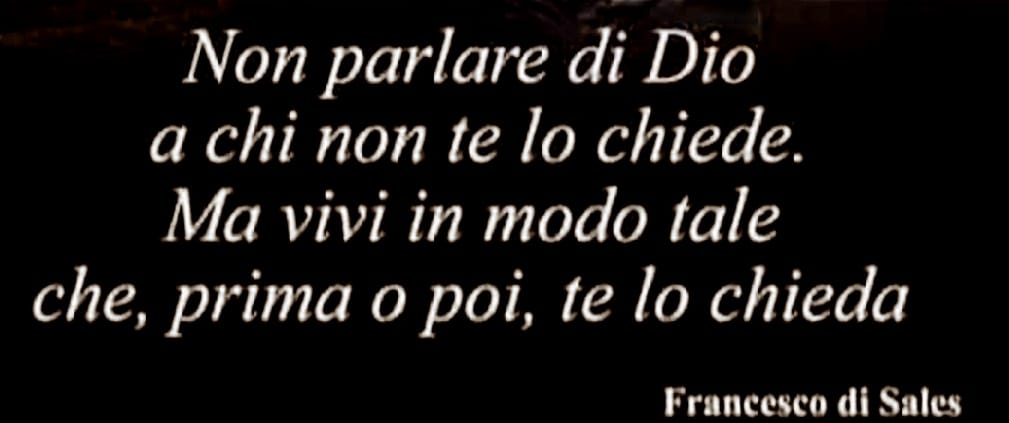
Le parole che non invecchiano sono quelle capaci di morire e di risorgere in ogni epoca. Una di queste è mitezza, che era già grandissima nei salmi, nel vangelo e nelle antiche civiltà orientali, ed è stata resa ancora più sublime dai grandi mansueti della storia – padre Kolbe, i tanti martiri di ieri e di oggi, Gandhi – e da tanti altri sconosciuti alle cronache che con la loro mitezza umile rendono ogni giorno migliore la terra di tutti.
La mitezza è la risposta virtuosa al vizio dell’ira, che mai come nei nostri tempi domina la sfera pubblica, incattivisce i nostri uffici, le nostre riunioni di lavoro o di condominio, il traffico urbano, le aule politiche. Se non ci fossero i miti, le nostre ire produrrebbero molte più guerre e ferite delle tante che producono già, e renderebbero invivibili le nostre città, che sarebbero dominate dalla reciprocità di Lamek, assassini, per un graffio, di fanciulli.
La mitezza di pochi cura e accudisce l’ira di tanti. Basterebbe questo per spiegare la preziosità indispensabile dei miti, che sono la prima minoranza profetica che eleva il mondo, il lievito madre, il sale primo della terra. Sono i veri non–violenti, perché con la loro fortezza impediscono alla violenza di dominare il mondo e i nostri mondi. La mitezza poi fa vivere, e vivere a volte gioiosamente, i malati cronici, fa invecchiare e morire bene, fa resistere nelle lunghe e dure prove della vita senza adirarsi e incarognirsi con gli altri e con se stesso, ma lasciandosi passare docili la mano sopra: sono i mansueti, coloro che “ad man um venire sueti”.
Quando a un certo punto, spesso improvvisamente e senza preavvisi, nella nostra vita arrivano la sventura e il dolore grande, l’allenamento alla mansuetudine rende i pesanti gioghi sostenibili. È la mitezza di Giobbe, che, seduto sul mucchio di cenere, non segue il consiglio della moglie («maledici Dio, poi muori»), e continua a vivere, a resistere, docilmente a lottare. In queste fase decisive della vita, la mitezza diventa esercizio doloroso e lieto di calarsi dentro la propria interiorità, trovarvi, nascoste, risorse e valori più profondi di quelli che attorno stanno vacillando o sono scomparsi. E si impara a dire “amen”.
Per dire bene, senza ira e cattiveria, gli “amen” più importanti della vita, l’ultimo soprattutto, è necessaria la virtù–beatitudine della mitezza. Un giorno un mio amico e maestro mite mi disse: «Se la vita ti mette in ginocchio una volta, rialzati; se ti ci mette una seconda volta, rialzati ancora. Ma se ti mette in ginocchio una terza volta, forse è arrivato per te il tempo della preghiera» (Aldo Stedile). Anche il perdono vero, quello che non è solo dimenticare per poi star meglio, che non è prendere (for–get) ma un dare (for–give), richiede la mansuetudine. Il mansueto è capace di perdono perché mentre perdona già si ripone docile, pronto a ricevere di nuovo la mano.
Nella tradizione ebraico–cristiana, la mitezza è associata all’eredità della terra. Di quale terra? La prima terra che i miti ereditano è la “terra promessa”, la terra dell’avvento di un regno di pace e di giustizia, agognato da ogni uomo e civiltà, ieri, oggi, domani. Ereditano prima di tutto il dono di occhi capaci di “vedere” questa Terra, e quindi desiderarla e amarla. Non si inizia, né continua, nessun viaggio, e non si attraversa nessun deserto se prima non si intravvede, e ancora prima desidera, al di là di esso il compimento di una promessa. Se non avessimo di fronte una terra promessa, nuova e migliore, come potremmo lottare, mitemente, per migliorare la nostra terra ferita?
L’eredità della terra, però, è anche quella che riceveranno domani i nostri figli se noi, oggi, saremo miti. C’è, infatti, una mitezza nell’uso della terra, delle sue risorse, dei suoi beni, dell’acqua, dell’aria, una mitezza di cui avremmo un estremo bisogno. Tutte le volte che siamo violenti con la terra e con le sue risorse stiamo diminuendo il valore della sua eredità. La mitezza è direttamente legata alla custodia: il mite Abele e il non–custode Caino sono ancora di fronte di noi come scelte radicalmente alternative, e sempre possibili. Chi è mite custodisce l’oikos (la casa) e quindi fa una oikonomia mite.
Una economia mansueta usa le risorse sapendo che le ha ereditate e che le deve lasciare in eredità. Se fossimo miti faremmo calcoli diversi per misurare la nostra crescita e il nostro benessere. In quegli algoritmi daremmo molto più peso al consumo di risorse non rinnovabili e a tutte quelle che abbiamo trovato sulla terra e che dobbiamo lasciare in eredità. La “destinazione universale dei beni”, principio base della dottrina del Bene comune, riguarda senz’altro lo spazio ma interpella, soprattutto, il tempo. Se facessimo così, la preoccupazione per il “dopo di noi” diventerebbe una cultura generale che ci porterebbe a usare tutti i beni comuni con la stessa cura con cui si usano le cose dei figli.
E invece il capitalismo individualista, che proprio in questi tempi di “crisi” si sta allargando incontrastato, è troppo spesso violento nell’uso delle risorse, e quindi baratta qualità dell’ambiente, dell’aria e dell’acqua di domani, il futuro di interi popoli (penso in particolare all’Africa), con qualche grado di temperatura in più o in meno nelle case del nord del mondo, e continua a mangiare, con golosità, terra, ambiente, poveri; non include le periferie, ma le divora.
La mitezza economica significherebbe, poi, soprattutto per le grandi imprese, ridurre l’aggressiva presenza della pubblicità in tutti i momenti della nostra vita, smettere di spremere i neolaureati che, in questa fase di scarsità grave di lavoro, sono molto ricattabili. Ridurre la velocità e l’aggressività della finanza speculativa, mitigare i linguaggi arroganti e volgari dei potenti, piegare e ammansire la mano di troppe banche verso imprenditori e famiglie, o quella della pubblica amministrazione con chi ha sempre pagato le tasse e ora, caduto in sventura, non riesce a farlo più.
La mitezza, allora, ci dice col suo linguaggio tipico, diverso ma profondamente legato a quello delle altre virtù e beatitudini, una verità antica, che si pone al cuore della vita in comune. Quando guardiamo lo spettacolo della vita che si compie ogni giorno di fronte ai nostri occhi, la prima impressione forte è che sono i furbi, i violenti e i malvagi a prevalere e ad aver successo. I miti appaiono come perdenti, scartati e soccombenti sotto i colpi dei potenti e dei violenti, un’iniquità che originò anche il grido deluso di dolore di Norberto Bobbio: «Guai ai miti: non sarà dato loro il regno della terra» (Elogio della mitezza).
Le storie e la verità della mitezza ordinaria e straordinaria ci dicono invece che questa prima impressione, pur reale, non è necessariamente quella più vera. Quando si fanno i conti dei ricavi e costi veri della vita individuale e sociale, che non si misurano principalmente in moneta, sono sovente le persone e le comunità mansuete a segnare il profitto più alto: «Io sono stato giovane e son anche divenuto vecchio, ma non ho visto il giusto abbandonato, né la sua progenie accattare il pane» (salmo 37). Se domani avremo una economia migliore dell’attuale, nella quale i giovani potranno lavorare e non più «accattare il pane», non sarà dovuto alle promesse dei potenti, ma all’azione forte, silenziosa e tenace di tanti mansueti. Beati i miti, perché erediteranno la terra.
